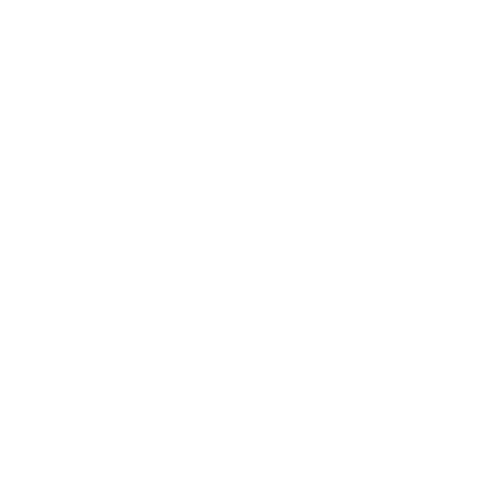La Rizza, risaia che diventa oasi
A Bentivoglio, tra aironi rossi, cicogne e piante idrofile
Parole di Lorenza Fraiese | Immagini di Stefania Andreotti | Giugno 2025
L’Oasi La Rizza oggi è una riserva naturale, ricca di boschetti, salici piangenti e tortuosi, gelsi monumentali, tritoni e una miriade di uccelli. Ci sono anche le cicogne, con i loro nidi spropositati! Una volta però era conosciuta come la risaia del Comune di Bentivoglio.
La coltivazione del riso occupava la zona nord di questo piccolo paese in provincia di Bologna, una zona che in origine era caratterizzata da natura paludosa, e che quindi assisteva a lunghi periodi di piene e di allagamenti: i fiumi vicini infatti nella maggior parte dei casi non erano arginati, oppure lo erano solo parzialmente. Questa grande area umida era tracciata principalmente dal Canale Navile, ossia il naviglio che proviene da Bologna: un tempo era una delle maggiori vie di trasporto merci, dalla città alla campagna. Oggi seguendo il suo corso si può pedalare comodamente dal capoluogo emiliano fino quasi a Ferrara.
Chiusa la risaia, l’area divenne un grande campo adibito alla coltivazione del mais e del grano e così restò fino al 1998. In quell’anno, grazie alla normativa sui ripristini e a una serie di contributi provenienti dalla Comunità Europea, vennero effettuati i primi lavori di recupero ambientale. In primo luogo venne effettuata la cosiddetta set-aside, ossia la messa a riposo dei terreni che permette la creazione dei polifiti, ovvero facilita la crescita di specie vegetali diversi sulla stessa superficie. In seguito furono organizzati i ripristini ambientali veri e propri, che hanno previsto la realizzazione di aree allagate, ovvero zone umide, e di aree macchia – radura, ovvero un mix tra prato naturale, alberi arbusti. Grazie a questi lavori si sono potuti ricreare degli habitat naturali, che sono andati via via arricchendosi sempre più, sia nella biodiversità della flora che della fauna.
L’oasi oggi è controllata e gestita dal Comune. Tra gli interventi principali programmati dall’amministrazione, durante il corso dell’anno, c’è la tranciature della vegetazione, effettuata nel periodo tardo estivo, quindi tra fine agosto e inizio settembre. Serve a rallentare la formazione del bosco e a mantenere giovane e rinnovato il canneto, il quale è in gran parte asciutto, ed in piccola parte allagato. Questo fattore è davvero importante, perché permette e facilita la nidificazione dell’airone rosso – specie protetta, decisamente meno comune del collega cinerino e del collega bianco. L’Oasi è caratterizzata da una importante zona umida, contraddistinta dalla presenza di un’isola più grande, centrale, circondata da un arcipelago di altre isole più piccole e dossi, che consentono la presenza di rive con acqua poco profonda, alternate a canali d’acqua dolce dove invece la profondità è maggiore. La profondità massima si trova nelle aree centrali del bacino.
Il livello delle acque è costantemente monitorato: durante il periodo che va dall’autunno alla primavera raggiunge il livello più alto, inizia a calare verso la fine di giugno. L’eterogeneità dell’avifauna presente in questo luogo è decisamente determinata da questo fattore: uccelli diversi prediligono profondità diverse. Approfittando della postazione dedicata al bird watching, che permette di osservare il comportamento degli animali da una postazione nascosta e riparata, si può notare che nelle acque più profonde si divertono i tuffatori, categoria a cui appartengono il tuffetto, la folaga e lo svasso maggiore. Nelle acque mediamente profonde si può osservare il martin pescatore, l’alzavola, l’anatra di superficie, il mestolone, la canapiglia e la moretta tabaccata. Ci sono anche le oche, che si dividono in due specie principali: la selvatica e la lombardella, anche se quest’ultima è in netta minoranza.
D’inverno la Rizza ospita circa 2500 anatre e tra le 900 e le 1000 oche selvatiche: non è poco, soprattutto se si considera l’originale destinazione del sito, votato alla monocoltura e all’agricoltura intensiva. La fauna comunque non si esaurisce qui, sempre tra gli uccelli è facile imbattersi in molte altre specie, dal classico airone cinerino, che costruisce i suoi nidi tra marzo e metà aprile, alle spatole, al cigno reale, al tarabusino, al cannareccione, che come descrive il nome abita soprattutto i canneti, al germano reale. Fino a qualche anno fa gli stagni abbondavano anche di testuggini, che però ora sono quasi scomparse, solo una piccola parte si conserva negli ambienti acquatici di dimensioni ridotte. Tra le frasche è facile individuare lo scoiattolo rosso europeo.
La flora è parimenti ricca e affascinante, soprattutto nella stagione delle fioriture. Gli appassionati di petali e boccioli possono davvero divertirsi qui, camminare tra i pallon di maggio e i piè di gallo, la canapa acquatica, i noccioli, le rose canine, gli iris di palude, il prugnolo e la fusaggine. Tuttavia non sempre lo sguardo riesce ad afferrare la difficoltà: tra foglie e petali tutto sembra vitale, prosperoso, eppure ci sono specie che stanno soffrendo. I problemi non si riscontrano tra chiome e cespugli, quelli crescono fin troppo bene. È la flora acquatica ad essere penalizzata: numerose piante idrofile – come la ninfea bianca, il morso di rana e il miriofillo – sono scomparse a causa delle nutrie e del gambero della Lousiana. Il danno provoca altri danni: è una catena. Senza queste specie l’acqua fatica ad auto-depurarsi e non è più possibile per tanti pesci autoctoni deporre qui le proprie uova. La tinca e il luccio non ce l’hanno fatta. Gli anfibi resistono per il momento, ma sono diventati rari. Per ovviare parzialmente a questa difficoltà si è costruito un argine dotato di barriera, che protegge le piante della nutrie e dal gambero: alcune idrofile si sono salvate e bisogna augurarsi che possano fortificarsi e ripristinare l’equilibrio dell’ecosistema.
Chi fosse curioso di conoscere questo posto non ha che da avventurarsi: verrà guidato dai cartelli, tra sentieri pedonabili e ciclabili. Potrà immergersi completamente nella bellezza naturale del luogo. Alle zone umide ci si può avvicinare ma con attenzione e rispetto: ci sono delle strutture schermate, che permettono di guardare senza disturbare. I principali punti di osservazione sono due, la Punta degli Olmi e Punta Canale. La prima è la più frequentata: è dotata di una torretta con piano rialzato e di un locale seminterrato, con una vetrata che permette di vedere alghe e pesciolini che nuotano. Essa inoltre non è distante dal Centro Visite: struttura importantissima per vari motivi. Oltre a organizzare attività, iniziative e laboratori, accoglie un gustoso ristorantino – consigliatissimo! – e un piccolo ostello.

Lorenza Fraiese
Redattrice
Studentessa universitaria, con una grande passione per la musica e la moda, ed un amore spropositato per i tramonti, il mare ed il buon cibo. Quando non rispondo al telefono è per tre motivi principali: o sto guidando, o sto dormendo, o sono immersa nello studio matto e disperato.

Stefania Andreotti
Caporedattrice di Interno Verde Mag
Omonima di una pianta tropicale, la Stephania, con base globosa e foglie sospese, lei ci si identifica: piedi nella terra e testa per aria. Ha scritto il suo primo articolo sul giornalino della scuola elementare e non si è più fermata. Coordina la redazione di Interno Verde Mag.