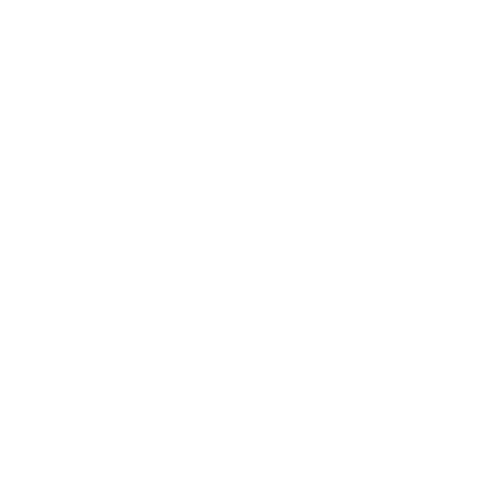Nel giardino di chi progetta i giardini
A casa della paesaggista Anna Scaravella, tra ricordi botanici e professione
Parole e immagini di Sabrina Tassini | Giugno 2025
Ci sono giardini dalle geometrie rigorose, alcuni indomiti, lasciati liberi di crescere secondo i capricci della natura. Altri sorprendono invece con discrezione, raccolti e così ben bilanciati da condurre altrove al primo sguardo creando varchi nell’immaginazione. Quello della nota paesaggista Anna Scaravella è tra questi. Si svela un passo alla volta, con quinte botaniche inaspettate ma dosate a dovere.
Siamo a San Polo, nella campagna alle porte di Piacenza, dove l’abbiamo incontrata per una chiacchierata tra agapanti, acanti e chaise longue. Ci accoglie negli spazi in passato destinati all’azienda agricola di famiglia al cui centro sorge un fienile, oggi convertito in una dimora che alla tipica vivacità dei contesti rurali affianca sofisticate scelte di design. Il “giardino personale” di Anna – come lei stessa lo definisce con affetto – è pièce maîtresse della casa. La introduce e la abbraccia con un irresistibile temperamento mediterraneo.
Poco importa se le nuvole velano il cielo, si è distratti da un verde magnetico che si insinua ovunque. Insiste e si arrampica persino sui muri in pietra dell’abitazione che pare dissolversi al suo interno. La sensazione è quella di trovarsi in un rifugio silenzioso interrotto solamente dal fruscio delle fronde.
Cosa rappresenta per lei questo luogo?
Le radici più profonde della mia vita. È qui che sono nata e cresciuta ed è inevitabile che io abbia con questa casa e questo giardino un legame speciale. Ricordo quando arrivava il catalogo Sgaravatti, all’epoca molto rinomato e con sede a Padova: lo sfogliavo con meraviglia fin da bambina, perdendomi tra immagini di sementi e varietà di piante. Impazzivo per le rose. Una in particolare, la Saint-Exupéry: la segnavo, la ritagliavo, pregavo mia madre di acquistarla.
Già allora il giardino esistente, un semplice spazio verde con pergole d’uva, era per me una sorta di mondo incantato. Con i miei fratelli ci divertivamo a costruire piccole vasche d’acqua con zampilli, raccogliendo ciottoli nel torrente vicino. Rammento anche l’emozione di quando le galline facevano i pulcini. Ho sempre respirato il ritmo della campagna, la sua concretezza ma anche la sua poesia. Proprio da questo credo sia nato il mio amore per la natura, il paesaggio e i giardini.
Che si è poi trasformato in una professione…
Qui conservo ricordi d’infanzia ma anche le prime intuizioni legate a quello che sarebbe diventato il mio lavoro. Dopo il liceo mi sono trasferita a Firenze per studiare Scienze Forestali, un percorso che mi ha permesso di approfondire scientificamente quanto fino ad allora era stata un’inclinazione istintiva. Dopo la laurea, ho lavorato con un architetto giapponese in Brianza – un’esperienza stimolante, che mi ha introdotta a una sensibilità progettuale misurata. Ma sentivo la necessità di toccare con mano, di immergermi nella materia viva del paesaggio. Così ho lavorato in Toscana, per sei, forse sette anni, in quello che oggi è uno dei vivai più importanti d’Italia. È stato un periodo di grande formazione, non solo dal punto di vista botanico – ho imparato a conoscere in profondità le esigenze specifiche delle piante, le loro reazioni ai diversi tipi di suolo e di esposizione – ma anche sotto il profilo tecnico e logistico. Progettare un giardino richiede infatti una conoscenza molto precisa del contesto: non basta scegliere le piante per affinità estetica, bisogna sapere come cresceranno, come volgeranno nel tempo. A differenza dell’architettura, dove i materiali restano invariati, nel giardino tutto è in continua evoluzione. Occorre saper prevedere gli accrescimenti, immaginare la fisionomia futura dello spazio, avere consapevolezza delle proporzioni finali. Spesso, chi non ha esperienza, teme il vuoto iniziale e tende a riempire troppo, ma la pazienza e la previsione sono fondamentali.
Dopo un percorso così ricco viene naturale chiederle come abbia messo a frutto le conoscenze in questo giardino. Come lo ha progettato?
Sono partita, come sempre faccio, da un approccio architettonico: prima la definizione degli spazi, delle zone funzionali, poi la scelta delle piante. Credo profondamente che un giardino debba essere abitato, per questo ho voluto creare aree diverse per vivere all’aperto: una più celata, dove poter pranzare in famiglia, un’altra più ampia per ospitare amici, e altre più silenziose, per sostare o leggere in tranquillità. Lo spazio a disposizione non è troppo ampio – circa 300 metri quadri – perché fa parte dell’originaria corte agricola. Ma questa misura contenuta mi ha permesso di dedicarmi con precisione a ogni dettaglio e ottenere un giardino intimo e molto personale.
Quali elementi e piante ha privilegiato?
Ho lavorato su una base solida, una sorta di impianto vegetale strutturale: una cortina di querce piramidali, che conferiscono verticalità; siepi di tasso, che amo molto per il loro profilo e la tonalità sempreverde profonda; un filare di carpini colonnari a nord, mentre a sud il bosso traccia un confine più delicato. In questo contesto ho sentito la necessità di alcuni mascheramenti, anche se di solito, soprattutto nei giardini di campagna, preferisco che il verde si dissolva naturalmente nel paesaggio. Ho scelto poi pochi alberi, principalmente da frutto, come il giuggiolo e il melograno. Non tanto per la funzione produttiva, quanto per il loro portamento architettonico. Ogni pianta ha caratteristiche formali ben definite ed è fondamentale che contribuisca in modo armonico al disegno d’insieme. Amo andare personalmente nei vivai, osservarle, sceglierle con cura. In questo senso, un libro che mi ha molto ispirata è L’architettura degli alberi di Cesare Leonardi, uno studio straordinario sul portamento delle diverse specie. Ci ricorda che gli alberi sono anche presenze spaziali oltre che organismi viventi.
Nulla sembra lasciato al caso ma c’è qualcosa che è emerso spontaneamente con il tempo?
Questo giardino ha ormai trent’anni. Lo avevo immaginato fin dall’inizio in modo molto preciso, nei minimi dettagli, e l’impostazione di base è rimasta intatta. Tuttavia, come sempre accade quando si ha a che fare con il vivente, qualcosa varia. Avevo già allora la consapevolezza di come le piante sarebbero cresciute, e in effetti molte di queste hanno finito per ombreggiare zone che all’inizio erano più aperte e luminose.
Certi cambiamenti sono nati proprio così: in alcune aree, ad esempio, si è diffusa spontaneamente una varietà di campanula, che ho lasciato prosperare. L’acanto, invece, è diventato quasi invasivo, ma non ho voluto contenerlo troppo: mi piace l’idea che le piante possano prendere spazio, se trovano le condizioni giuste.
Fin dall’inizio ho privilegiato specie robuste, capaci di adattarsi con autonomia: ho un impianto d’irrigazione solo per il prato, mentre le aree arbustive devono cavarsela da sole (sorride). Alcune piante, purtroppo, si sono perse – come gli iris, che amo molto e che sicuramente reintrodurrò.
Immagino che un giardino così vissuto sia in qualche modo anche terreno di sperimentazione. Lo utilizza per testare soluzioni che poi applica anche nei progetti che cura?
Assolutamente sì, soprattutto per quanto riguarda le piante basse. Negli anni, ho vagliato moltissime combinazioni. I cambiamenti nell’ombreggiamento, ad esempio, mi hanno permesso di osservare la loro risposta. Tutte le sperimentazioni si sono rivelate preziose per il mio lavoro: mi hanno aiutata a valutare la resilienza di alcune specie, in particolare quelle a bassa manutenzione – una richiesta che ricevo spesso dai miei clienti.
Progettare giardini per le persone implica anche entrare in connessione con i loro desideri, le loro abitudini…
È un aspetto che mi sta molto a cuore. La partenza di ogni progetto non può prescindere dalla personalità del committente: bisogna essere un po’ psicologi, ascoltare con grande attenzione, fare domande mirate. Il giardino è sempre un sogno, un desiderio di relazionarsi con la natura che nasce da una passione per il verde. Per questo mi piace assecondare, nel senso più profondo del termine: non significa eseguire passivamente, anzi. Se qualcosa non funziona, va detto con chiarezza. Ma cerco di fare in modo che il giardino, una volta realizzato, possa davvero appartenere a chi lo vive. Mi capita di tornare in giardini che ho progettato, a distanza di molti anni, e vedere che tutto è rimasto inalterato. Questo mi rende felice, significa che quel luogo è stato amato ed è per me motivo di grande soddisfazione.
Cos’altro trova appagante del lavorare con spazi verdi?
Il verde è vivo, trasmette energia. Standoci a contatto, scatta un meccanismo inconscio che si traduce in percezioni positive tangibili, per il corpo e per la mente. Ti rigenera. Anche la scienza lo ha confermato ma chi lavora con la natura lo sa da sempre, lo sperimenta ogni giorno. Mi colpì il progetto di Padre Eligio a Cetona: aveva trasformato un antico convento nella Frateria, un luogo di accoglienza e riabilitazione dove ragazzi in percorso di recupero dalla dipendenza gestivano sia un ristorante di grande qualità, sia l’orto e il giardino circostanti. Prendersi cura della terra restituiva loro equilibrio, fungeva da terapia attiva.
Per quanto mi riguarda il verde è un antistress infallibile. Bastano pochi minuti in giardino e già mi sento meglio. Le idee migliori, le intuizioni più limpide, ad esempio, mi vengono spesso mentre cammino lungo un torrente, o pedalo tra i paesaggi apparentemente semplici della Pianura Padana. Ci sono zone meravigliose, con boschi ripariali, praterie spontanee, piccole ma interessanti variazioni. La natura, quando la osservi attentamente, non è mai banale.
E cambia con le stagioni… c’è un momento in cui preferisce ammirare o sostare in questo luogo?
Lo amo in ogni stagione, ma naturalmente primavera e inizio estate sono i periodi ideali in cui vivere all’aperto: le giornate sono lunghe, il clima è dolce, la vegetazione è nel pieno della sua espressione. Adoro in particolare le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio: la luce accarezza le forme e ammorbidisce i contorni. Anche l’inverno ha un fascino tutto suo. Quando nevica, i bossi si coprono di bianco e il giardino si trasforma in una visione quasi fiabesca, rarefatta.
In generale, ha riscontrato un cambiamento nella percezione degli ambienti esterni?
Senz’altro. Oggi il giardino è vissuto come estensione della casa, un luogo da abitare, non solo contemplativo. È diventato uno spazio da vivere appieno, con angoli attrezzati per mangiare, rilassarsi, accogliere. Trent’anni fa, l’arredo da esterno si limitava alle classiche poltroncine di ferro: oggi i grandi brand realizzano vere e proprie collezioni di design per arredare “stanze” all’aperto. È un sintomo evidente di un cambio di rotta.
Questa nuova attenzione è positiva, ma porta con sé anche qualche contraddizione. Se da un lato c’è più desiderio di verde, dall’altro si tende a dimenticare che il giardino richiede impegno: serve manualità, conoscenza, dedizione. La cultura del giardinaggio, quella profonda, esperta, si sta un po’ perdendo, e con essa anche il piacere della fatica legata alla cura.
Altra nota dolente risiede nelle mode, spesso importate senza una vera consapevolezza. Prendiamo ad esempio il lavoro di Piet Oudolf, grande paesaggista olandese, oggi punto di riferimento internazionale. Il suo stile — che richiama una natura apparentemente spontanea, fatta di graminacee e perenni — ha avuto un enorme impatto a livello globale. Ma ciò che funziona nei Paesi del Nord, con un clima e un suolo completamente diversi, non è detto che sia sostenibile altrove.
Qui si tenta spesso di replicare quelle suggestioni con piante non autoctone e ad altissima manutenzione, dimenticando che oggi — con il cambiamento climatico — dovremmo privilegiare alberi e arbusti capaci di offrire ombra e resistenza. Un giardino ben progettato è fatto di strati, proporzioni, soluzioni adatte al luogo. La moda può ispirare, ma va sempre declinata nel contesto, altrimenti rischia di generare solo dispendio, senza vera qualità.
Riguardo alla necessità di progettare giardini più consapevoli, anche in ottica climatica, qui il verde dialoga fortemente anche con l’architettura dell’abitazione: ovunque si guardi, dagli interni, si incontra la natura. Quanto è importante questa interazione?
È fondamentale. Il verde non è solo una cornice decorativa, può diventare elemento essenziale del progetto architettonico, contribuendo anche al comfort abitativo. Ad esempio, ho scelto personalmente rampicanti e alberi da piantare nei punti strategici: d’estate mi offrono ombra, mentre d’inverno, perdendo le foglie, permettono al sole di filtrare e riscaldare le stanze. Certo, il vecchio fienile era già ben orientato e progettato in origine, ma l’interazione con il verde lo ha reso ancora più efficiente e confortevole.
Si intravede anche un orto… (e in cucina, alcuni cesti colmi di verdure appena colte, ndr)
Sì, c’è una zona del giardino dedicata agli ortaggi. In questo momento stiamo raccogliendo tantissime fave e piselli, ma anche ribes, lamponi e ciliegie. Abbiamo poi una piccola serra che d’inverno ci permette di coltivare insalate, cavoli, biete, catalogne.
Anche la percezione dell’orto è molto cambiata nel tempo. Da zona nascosta, considerata di servizio, oggi invece è spesso esposta, ben visibile, quasi decorativa. E in effetti è bellissima: vivace, colorata, in costante mutamento. È una gioia immensa poter raccogliere direttamente dal giardino, fare marmellate, cucinare con quello che cresce qui.
Ecco, il giardino ideale per me è anche questo: un luogo che unisce bellezza, natura e quotidianità. Amo progettare spazi raffinati, anche in contesti urbani molto eleganti – come è accaduto, per esempio, per il negozio Dior a Parigi – ma resto profondamente legata alla dimensione autentica e bucolica della campagna. Trovo il verde prezioso non solo come caratteristica estetica ma come parte integrante della vita di ogni giorno.

Sabrina Tassini
Redattrice
Giornalista e lifestyle editor, emiliana di nascita e globe trotter per vocazione. È appassionata di vintage e design, ama il jazz, i tortellini, il Giappone e i libri antichi. Non potrebbe vivere lontana dalla natura, senza il cinema francese, la scrittura e l’ironia.