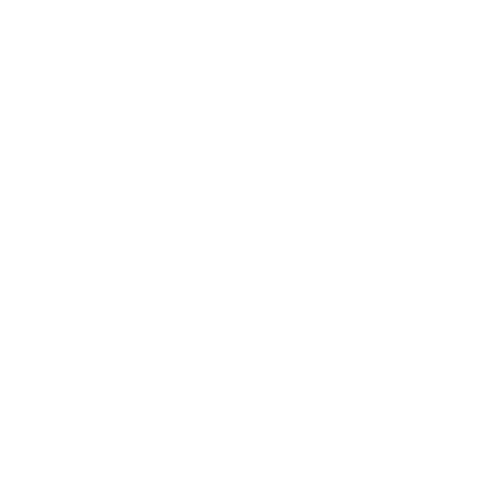Orti Generali, la rinascita di Mirafiori
Nello storico quartiere operaio, agricoltura sociale e mucche scozzesi
Parole di Sabrina Tassini | Immagini di Giuseppe Moccia | Settembre 2025
Rigenerazione, inclusività e cura per l’ambiente sono i pilastri dell’iniziativa torinese Orti Generali, nata dal risanamento di un parco fluviale a lungo dimenticato e ridotto al degrado. In uno scenario che vede il termine “sostenibilità” spesso svuotato di senso e piegato al greenwashing, esperienze come questa accendono un faro su recuperi autentici, capaci di generare nuove opportunità e forme di aggregazione sociale.
Ne abbiamo parlato con Stefano Olivari, architetto paesaggista e curatore del progetto, per capire come un’area residuale possa trasformarsi in un laboratorio vivo di agricoltura urbana per la comunità.
Ci racconta in cosa consiste Orti Generali?
Il progetto nasce nel 2018 con l’obiettivo di creare un modello di impresa sociale all’interno di un parco nel quartiere periferico di Mirafiori sud, a Torino. Si voleva restituire alla cittadinanza un’area abbandonata da molti anni e segnata da abusivismo e incuria, offrendo a oltre 250 famiglie la possibilità di vivere l’orticoltura urbana come occasione di integrazione sociale e culturale. Ad oggi, Orti Generali conta la realizzazione di 170 orti su circa 12 ettari e la riqualificazione di un ettaro di orti abusivi, volti a polo didattico, fattoria urbana e orto collettivo. Consideriamo che tutto ciò si inserisce in un contesto che negli ultimi vent’anni ha vissuto un’evoluzione significativa. Mirafiori era un quartiere ghetto, nato da per l’industria del Novecento. Ha avviato un percorso di rigenerazione con il Programma di Recupero Urbano del 2005 e con la nascita della Fondazione di Comunità di Mirafiori. Oggi è un quartiere vitale, arricchito da numerosi spazi verdi e dal torrente Sangone, che ne segna il limite urbano e ne rafforza il legame con la campagna. Restano alcune criticità, ma proprio la sua posizione e la varietà sociale lo rendono un territorio di grande potenzialità.


Partendo da una zona così trascurata, non sarà stato semplice avviarne la riqualificazione e raggiungere l’obiettivo…
La trasformazione di quest’area agricola ha richiesto innanzitutto una profonda ricerca storico-paesaggistica e un percorso di progettazione partecipata dal basso. Fin dall’inizio abbiamo cercato di coniugare la componente sociale, coinvolgendo volontari ed enti del terzo settore, con l’impegno scientifico e l’innovazione tecnologica. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla qualità paesaggistica, preservando le tracce dei sistemi agricoli preindustriali: in primo luogo i canali di irrigazione seicenteschi, un tempo al servizio dei giardini dell’antico castello di Mirafiori, oggi quasi del tutto scomparso.
Parlando degli orti, come funziona la loro gestione e in che modo si traduce in opportunità concrete di inclusione e partecipazione per la comunità?
Già in fase di progettazione abbiamo individuato la necessità di rendere l’esperienza di trasformazione e gestione collettiva degli spazi un’occasione di inclusione di soggetti con fragilità di tipo sociale ed economico. L’assegnazione stessa degli orti, attraverso una precisa gestione economica dei contributi richiesti, rappresenta un meccanismo interno di redistribuzione finalizzato a concedere l’accesso alla terra a tipologie di cittadini diverse per capacità contributiva ed età. Gli ortolani solidali sono quelle persone che hanno meno risorse economiche, pagano una cifra simbolica per l’uso dell’orto e in cambio aiutano per dieci ore al mese Orti Generali nella gestione, con un sistema ispirato alle banche del tempo. Metà del personale interno viene poi dedicato all’accompagnamento di soggetti fragili su percorsi specifici che vanno dal reinserimento sociale all’inserimento lavorativo, dalla formazione alla sperimentazione positiva di sé, in particolare attraverso la creazione di un ambiente accogliente. Grazie al gruppo dei volontari, dei tirocinanti, dei civilisti, degli ortolani solidali, degli stagisti e dei vari utenti che a diverso titolo sono coinvolti in percorsi abilitativi, si è quindi sviluppata una comunità operosa che si confronta adoperandosi in attività pratiche e produttive. L’idea è che la mixitè stessa sia strumento di trasformazione e di opportunità per connotare i luoghi non con fattori strutturali – come reddito e assenza di proprietà – ma interessi come la domanda sociale di paesaggio, che da tempo esprime la popolazione della periferia urbana.
La dimensione sociale che caratterizza Orti Generali si riflette anche nel paesaggio, che non è statico ma cambia nel tempo e con il contributo della collettività. In questo contesto, come si riesce a progettare l’impermanenza senza rinunciare alla coerenza formale?
L’impermanenza si progetta con la transitorietà, per esempio le recinzioni, i capanni e gli arredi non hanno basamenti in cemento e sono realizzati in legno di castagno, tagliato e lavorato in provincia di Torino da una cooperativa sociale. L’assenza di cemento e basamenti permette la rimozione di tutti gli elementi degli orti senza pregiudicare un diverso uso agricolo dei suoli in futuro. Le città e gli usi evolvono in fretta e occorre preservare in ogni modo i pochi terreni fertili superstiti ancora presenti nel tessuto urbano per le future generazioni. La coerenza formale è data da queste caratteristiche di grande semplicità ed economicità dello sforzo e della spesa, è quindi più un esito che un’intenzione.
Coltivare un orto implica dedizione ma anche competenze che non tutti possiedono. In che modo supportate chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa attività?
Per facilitare chi inizia e rendere l’esperienza più accessibile, tutti gli orti sono dotati di un impianto di irrigazione automatico collegato a una stazione meteo avanzata posta al centro dell’area. La stazione rileva l’umidità del suolo e, quando il terreno è asciutto, attiva le elettrovalvole di irrigazione soltanto se c’è meno dell’85% di probabilità di pioggia. Oltre a questo, monitora temperatura, vento, precipitazioni e bagnatura fogliare. I dati raccolti vengono elaborati da un sistema informatico con algoritmi specifici che aiutano a prevenire le fitopatologie. In base alle condizioni climatiche, sul sito open source di Orti Generali compaiono le possibili malattie che possono colpire le coltivazioni in quel momento, con indicazioni su come riconoscerle e curarle con metodi biologici.

Oltre all’esperienza quotidiana di coltivazione, sono previste anche iniziative speciali?
Nel corso dell’anno organizziamo numerosi appuntamenti pensati per favorire inclusività, partecipazione attiva e sensibilità ai temi ambientali, senza dimenticare l’accoglienza per famiglie e visitatori. La programmazione è molto variegata: comprende una rassegna cinematografica di cortometraggi sulla sostenibilità, eventi dedicati al riuso degli scarti in cucina e alla riduzione dello spreco alimentare, lezioni aperte sulla food forest, oltre a un lungo weekend comunitario incentrato sulla preparazione della passata di pomodoro come momento di aggregazione sociale. Tra gli appuntamenti più sentiti c’è anche un galà di beneficenza, dove ortolani e cittadini condividono piatti cucinati insieme, e una festa scozzese che celebra la nascita di Gino, il primo vitellino venuto al mondo in un parco urbano. A questi si aggiungono cinema all’aperto, mercatini dei produttori e dell’usato, giornate dedicate all’ecologia con attività pratiche come la messa a dimora di food forest, la cura del sistema fluviale o gli innesti. Inoltre, le attività didattiche, tra scuole, centro estivo e laboratori, coinvolgono ogni anno oltre 3.500 bambini.
Orti Generali dispone anche di un chiosco per il ristoro, qual è la sua proposta e quale filosofia la guida?
Il chiosco utilizza i prodotti coltivati negli orti e, in parte, quelli di agricoltori locali. La cucina è esclusivamente vegetariana e vegana, ed è aperta nei weekend per i frequentatori del parco e degli orti. Negli anni, anche grazie a progetti europei, abbiamo sviluppato un’attenzione particolare alla circolarità: dall’impiego degli ortaggi meno pregiati alla valorizzazione degli scarti fino al compostaggio. Tutti i prodotti da forno sono realizzati con farine di Stupinigi, la campagna agricola più vicina al nostro quartiere, ottenute da miscele di grani antichi e a bassa forza macinati a pietra. Il pane è sfornato dal panificio Panacea. Inoltre, facciamo parte del presidio Slow Food Comunità Urbana Mirafood.
Si scorgono qui vicino anche le splendide Hairy Coo, le mucche scozzesi dal manto lungo e ramato…
Le mucche scozzesi vivono in un’area di oltre un ettaro gestita a eco-pascolo e si trovano proprio al centro del parco e dello spazio pubblico, così da poter essere ammirate e contemplate. È un modo per ribaltare la consueta logica antropocentrica con cui vengono progettati i parchi urbani, mettendo invece al centro gli animali. La loro presenza è preziosa anche dal punto di vista ecologico: l’erbivoria contribuisce infatti al mantenimento della biodiversità, arricchisce i suoli e la flora e sostituisce lo sfalcio meccanico, evitando l’uso di macchinari alimentati da combustibili fossili. Oltre alle mucche abbiamo poi un apiario e un pollaio con galline di razza Bionda Piemontese e Millefiori, donate dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Torino.

Che riscontri avete avuto dal momento dell’apertura sino ad oggi da parte della cittadinanza?
Orti Generali ha suscitato interesse sin dal primo momento. Oggi abbiamo una lista d’attesa di circa mille persone per ottenere un orto, mentre eventi come il Gran Galà o la Social Passata registrano sempre il tutto esaurito. Grazie alle sue caratteristiche innovative, l’esperienza è diventata un riferimento anche a livello istituzionale, studiata in diversi casi di pianificazione strategica per la gestione delle aree agricole urbane, come il piano delle infrastrutture verdi della Città di Torino. Il progetto ha inoltre richiamato numerose delegazioni internazionali – dalla Francia alla Corea del Sud – ed è al centro di collaborazioni scientifiche con diverse facoltà universitarie, da Architettura a Economia, Biologia, Agraria, Veterinaria, Scienze Gastronomiche e Scienze dei Beni Culturali. Nel 2023 abbiamo ricevuto il Premio Nazionale del Paesaggio del Ministero della Cultura e siamo attualmente presenti alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.
E come immagina Orti Generali in futuro?
Aperto. Si spera.

Sabrina Tassini
Redattrice
Giornalista e lifestyle editor, emiliana di nascita e globe trotter per vocazione. È appassionata di vintage e design, ama il jazz, i tortellini, il Giappone e i libri antichi. Non potrebbe vivere lontana dalla natura, senza il cinema francese, la scrittura e l’ironia.